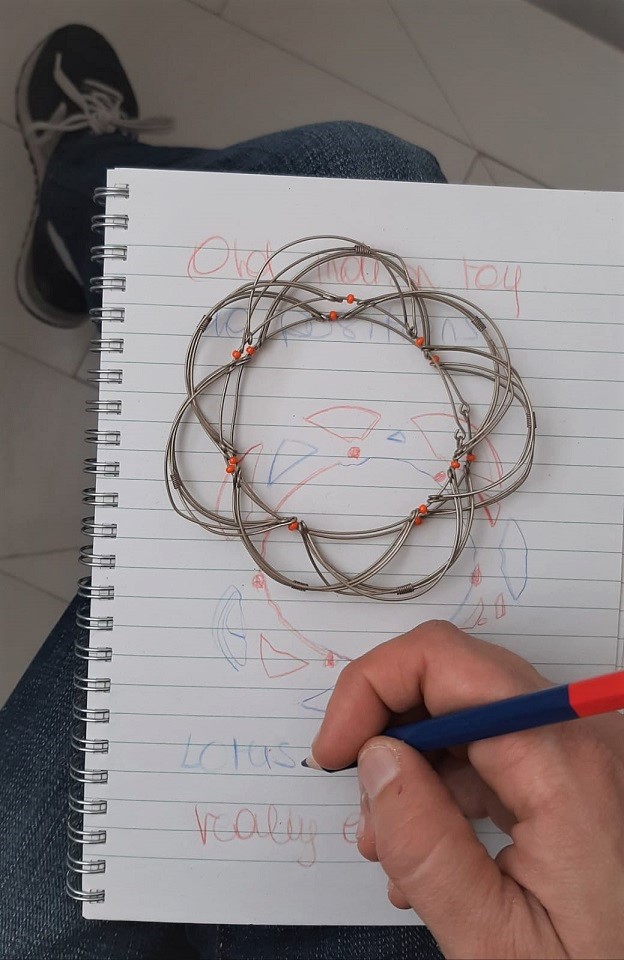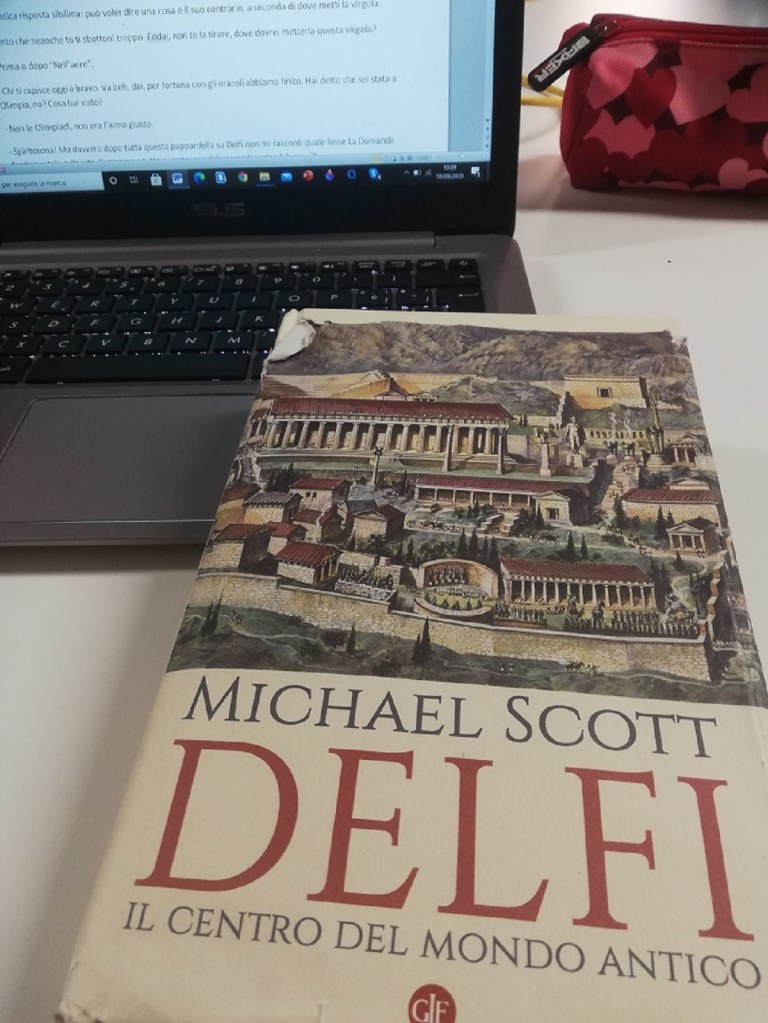Tag
aspirante scrittore, brioche, esordiente, Ferragosto, max gazzè, musica, Natale, racconti, scrittura, scrivere, writing
(per dirla con Max Gazzè)

La solitudine arriva presto, pezzo a pezzetto, e con te rimane. Arriva senza che te ne accorga e non se ne va mentre sorridi, quando a Natale vi abbracciate a tavola, se al Ferragosto sole in terrazza e gavettoni tutti, tutti voi che ve ne state insieme. Poi passa l’anno, torna un altro Ferragosto e… manca una persona.
– Una sola, che sarà mai.
– Sarà eccome.
A Natale ne mancano due, di convitati, tra chi cresce e chi se ne va più gatti vari che scappano o muoiono, e tu sei lì a guardare chi hai, e la casa che sembra comunque piena di un giorno festoso; qualche mese dopo sei un’altra volta a crudo e melone nel dehor sul mare più arachidi e Gin Tonic che si fa uno strappo alla dieta, se oggi siamo tutti insieme.
La solitudine è ancora lì, in quei momenti è con te che proprio non lo capisci e allora procedi campione, va’ avanti e conquista; finché a un certo punto. Si fa toccare. La tocchi. È fredda, la solitudine. È fredda anche a Ferragosto, quando il sole scalda che sembra cuocere e vai al bar solito che tutti trascurano per la nuova croissanteria fighetta che ha aperto all’angolo. E sei in coda, una coda che non ti aspettavi lì, al bar di solito vuoto, una coda calda in questa feria d’agosto insieme agli altri estranei, a tutti gli altri che sorridono in fila e pregustano la loro calda giornata di festa.
Ma poi. Scambio di sguardi col vecchio che ha un tocco di focaccia, lo tiene come le paste per sua moglie e i figli quando sua moglie c’era e lui interessava ai figli, quando comprava cavolini e bignè mi dia soprattutto quelli alla crema e aspettava fuori da messa col sorriso e i dolci in grembo, e ignorava il rimprovero di lei dacché non era entrato in chiesa, e rincasavano con passo da domenica a mangiare il buono che era già pronto all’alba. Ora ti guarda lui, il vecchierello dalla polo a righe e macchie, ti guarda con quel suo cane ignaro e ti fa capire che lui invece sa, sa quel che viene e sa che ci sei anche tu lì dentro, vi riconoscete nella solitudine della vostra festicciola sobria.
Esci con un groppo allo sterno, proprio sotto la gola, un magone al petto che ti mangia dentro, così tanto che non senti più fame: prendi la tua brioche al cioccolato nella carta spessa che non unge e ti avvicini al cesto della spazzatura, ché tanto la solitudine sazia. Devi cercare di fartela compagna, quella. Tempo ne hai, hai ancora anni, ora che sai di averla al tuo fianco. E devi ammansirla devi, perché se no la solitudine fa male, arriva a un punto che diventa brutta, così di colpo, e non ti dà tregua. Se la coltivi, invece, un po’ ti è amica: o la prendi con te, la solitudine, o entra a forza e poi ti espugna e sbrana.
Vorresti buttarla, quella dannata brioche, sbatterla sul fondo del cestino e schiacciarla bene col pugno ma non lo fai, tuo malgrado non lo fai perché il cestino è pieno e la brioche non ci starebbe e ancora non lo fai, se no finisce la tua parvenza di Ferragosto e la solitudine diventa vera.
Poi l’inverosimile, se succedesse in un libro o alla tivù non ci crederesti: cade la brioche al cioccolato, cade e pensi non è atterrata male, tanto è protetta dalla carta. Ti chini, la afferri, la osservi e però il sacchetto è a rovescio, la brioche sguscia e cade sull’asfalto del marciapiede. La raccogli subito e pensi sono passati meno di cinque secondi, se soffio posso mangiarla e non succede niente ma poi guardi a terra, tra chiazze di pisciata e piume e cicche e altro, no non si può, che schifo. E subito la solitudine ti è appollaiata in spalla.
Intanto è cambiato davvero il tempo, come era scritto in agenda. Piove forte e ristora, ma qualcuno no. No chi è in guerra, no chi quattro anni fa attraversava il ponte. No chi vuole tornare col culo in spiaggia, oggi, in attesa che arrivi il suo turno.
– Il turno di cosa, per comprare le brioche?
– Ma no, che dici, il turno per… lascia perdere, buon Ferragosto.
…a farsi da mangiare. (Per chiudere con Max Gazzè)